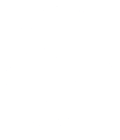La produzione dei latticini
La lavorazione del latte e la produzione dei derivati era svolta sia in ambito domestico dalle famiglie di allevatori che dai casari nelle loro latterie, di solito affiancate agli alpeggi, ai monti o alle stalle nei paesi di pianura.
La lavorazione seguiva diverse abitudini in base al periodo, al numero di capi posseduti e alla loro produttività.
Nel passato, possedere due o tre mucche in una zona comunque povera era un privilegio per pochi, perciò spesso si tagliava il latte bovino con quello di pecora; oppure si produceva formaggio magro per sfruttare il grasso del latte vaccino per la produzione di burro.
-
Il burro
Il latte veniva filtrato e versato in grossi recipienti di rame; questi venivano disposti in ambienti freschi e a temperatura costante, di solito delle piccole baite in pietra (i casinel), e venivano immersi in acqua corrente che ne manteneva la temperatura costante. Dopo una o due notti sulla superficie del latte affiorava la parte grassa del liquido: la panna, con la quale veniva prodotto il burro. Per dividere il latte dalla panna si utilizzava una paletta, di solito di legno – ma ne esistevano anche di rame o zinco – detta schiumarola. La panna raccolta veniva versata nella zangola (penagia in dialetto), un cilindro di legno chiuso, dotato in cima di uno stantuffo atto a mescolare il liquido. Questa veniva prima riscaldata con acqua calda, perché le alte temperature favorivano la trasformazione da panna a burro. Sbattendo il liquido con movimenti lenti e continui all’interno della zangoa si ottenevano il burro e un liquido bianco, il lat de penagia (latte di zangola).
Il burro veniva prima lavato in secchio, poi sbattuto e impastato su un ripiano, in modo da eliminare ogni traccia di liquido; infine, veniva inserito in stampi di legno, di solito acero o faggio, ognuno con il simbolo proprio dell’allevatore, per ottenere la forma adatta al confezionamento. Ottenuta la forma, lo stampo veniva rimosso e il burro inserito in acqua fredda e poi confezionato.
Lo scarto della lavorazione, il lat de penagia, non era sprecato: veniva utilizzato per nutrire i maiali insieme all’acqua di lavaggio degli utensili utilizzati. -
Il formaggio
Si tratta di un alimento antichissimo, sfruttato da tempi immemori dall’umanità come la fonte principale delle proteine.
Esistono innumerevoli tipologie diverse di formaggio, le quali dipendono dalla stagione di produzione, dal tipo di lavorazione e dal latte: se scremato (senza la panna) il formaggio ottenuto è di tipo magro, se intero il formaggio risulterà grasso; spesso al latte scremato vengono aggiunte delle parti di latte intero, di solito quello munto al mattino, e il risultato è il formaggio semigrasso; qualche volta il latte vaccino viene anche tagliato con latte ovino, di solito di capra.La lavorazione del formaggio era un processo non facile, e necessitava una buona capacità da parte del casaro. Il primo passo era, ovviamente, la mungitura, che doveva avvenire tutte le mattine e tutte le sere. Gli allevatori utilizzavano un richiamo vocale per richiamare la mandria e, muniti di un sedel (secchio) e di uno sgabello, provvedevano a mungere le mucche.
Il latte raccolto veniva poi trasportato nella latteria e versato nella culdera (caldaia), una grande conca di rame a forma di pentola. La culdera è montata su un braccio mobile, per poterla allontanare o avvicinare al fuoco secondo le necessità.
La temperatura del latte dipendeva dal tipo di formaggio che si voleva produrre: in generale variava dai trenta ai trentadue gradi per quello magro o semigrasso, ben più alta, intorno ai quaranta gradi, per quello grasso. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, la culdera veniva allontanata dal fuoco per aggiungere il caglio. Il caglio è una sostanza provvista di un enzima contenuto nelle ghiandole presenti nel quarto stomaco dei ruminanti, l’abomaso, estratto quando gli animali sono ancora in fase di allattamento. Di solito veniva utilizzato il caglio bovino, qualche volta anche quello di capra o pecora. Le ghiandole venivano estratte e fatte seccare e affumicare, di solito con i camini delle abitazioni, poi pestate con un mortaio in modo da ottenere un impasto da conservare in vasi. Per ottenere il caglio vero e proprio si mescolava l’impasto ottenuto con del pane nero di segale, noci e qualche nocciolo di pesca. Il caglio veniva versato nella culdera a piccole dosi, dopo essere stato sciolto in acqua calda. Al giorno d’oggi il caglio utilizzato è di tipo industriale, solo pochissimi seguono ancora l’antico procedimento.
Dopo circa quaranta minuti dall’aggiunta del caglio si formava la cagliata, una massa gelatinosa composta dal grasso condensato del latte. Questa galleggiava in una sostanza biancastra chiamata siero, la parte liquida del latte. Dalla temperatura della cagliata dipendeva la consistenza del formaggio: con più era alta più questi risultava duro e viceversa.
La cagliata veniva prima frantumata con la schiumarola (o frangicagliata) e poi raccolta con l’aiuto di un telo. In contemporanea si preparava lo stampo della forma di formaggio: un cerchio di legno chiamato fascera, circondato da una cordicella utilizzata per circuire la forma e stringerla, in modo da renderla più compatta. La fascera era posta su un’asse inclinata, il colatoio, sulla quale colava il siero rimasto. Sopra la forma si metteva un peso, di solito un sasso, e veniva lasciata riposare per ventiquattro ore circa. Terminata questa fase, la forma veniva salata e portata nelle cantine per la stagionatura. Tali ambienti erano muniti di scaffali in legno per accogliere le forme, e mantenevano la medesima temperatura e il giusto grado di umidità. Periodicamente la forma veniva pulita, girata e cosparsa nuovamente di sale. Tempi diversi di stagionatura determinavano sapori diversi di formaggio, ed erano a discrezione del mastro casaro.